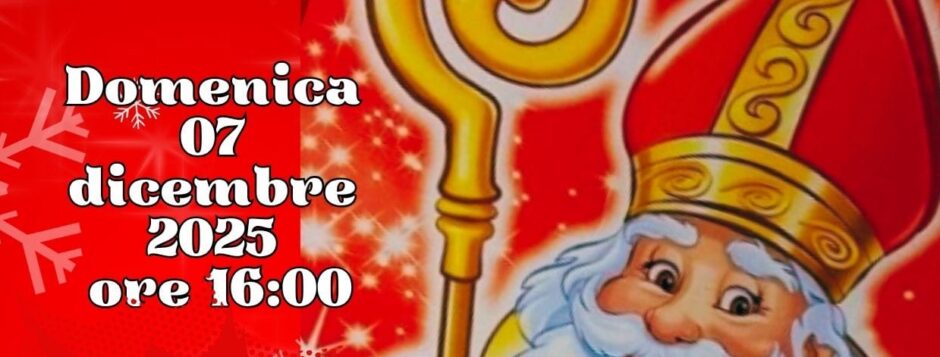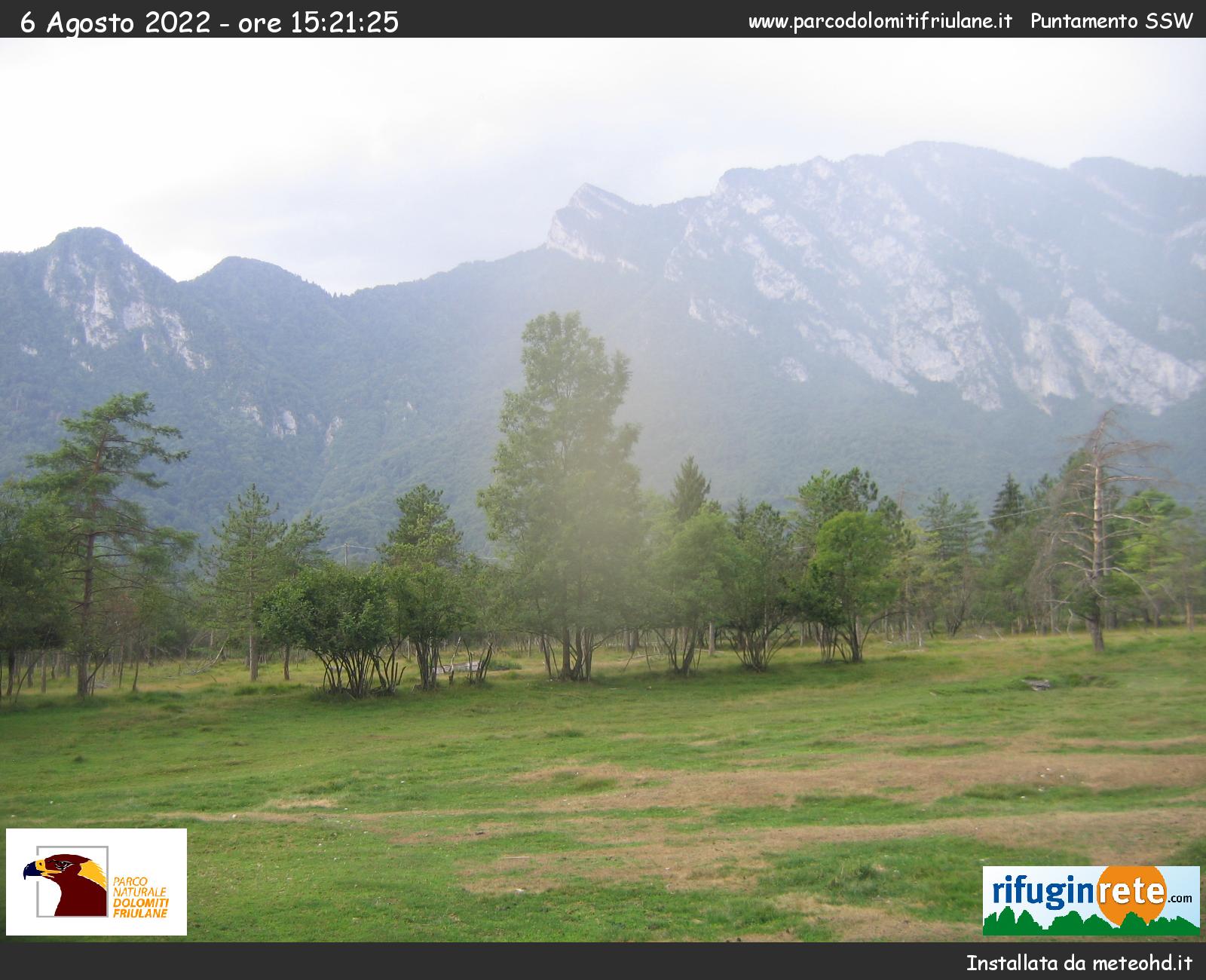I riti di passaggio nella tradizione cristiana a cura di Don Luca Basaldella
BATTESIMO
Senza voler essere esaustivi, solo per dar un veloce inquadramento alla questione, possiamo asserire che da sempre, il Battesimo, è porta d’ingresso alla comunità dei cristiani. Esso, come elemento portante, non considera solo il rito, che per essere Sacramento efficace deve sostanzialmente comprendere l’elemento dell’acqua (ferma, non alterata), le parole del celebrante (“io ti battezzo, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito santo) e l’intenzione (in comunione alla volontà di tutta la Chiesa), oltre a questo s’aggiunge l’impegno di tutti i battezzati, cioè di tutti i cristiani, nell’accompagnamento di coloro che passano a vita nuova attraverso il fonte battesimale, o battistero. Il Battesimo pertanto non è solo un rito, ma connota tutta la vita del battezzato.
Alle origini, i credenti desiderosi di partecipare alla via di Cristo chiedevano questo dono, seguendo le parole che Gesù stesso aveva lasciato come eredità (così in Matteo 28, 19-20). Moltissimi furono i battezzati nei primissimi tempi. In breve venne anche data una forma più solenne a questo rito di ingresso. C’è da ricordare che le nuove famiglie diventate seguaci del Cristo Risorto iniziarono da subito a voler battezzare i propri figli ancora in fasce. Il Battesimo degli infanti pertanto è da considerale una vera Tradizione della Chiesa secondo la testimonianza degli stessi Apostoli (gli inviati di Gesù Cristo).
Gli elementi portanti del rito che possiamo ritrovare già nei primi secoli sono: la rinuncia a Satana, la Professione di Fede, la benedizione dell’acqua, il battesimo vero e proprio e altri segni (in particolare la veste bianca e il cero). Molto antico è anche l’uso di celebrare il Battesimo durante la Veglia Pasquale, come attesta già il prezioso testimone Tertulliano di Cartagine, vissuto fra il 160 e il 240, nella sua opera ‘De Baptibsmo.
Nelle epoche successive, nel pressi delle basiliche, vennero costruiti dei veri e propri edifici sempre più imponenti, generalmente a pianta circolare od ottagonale, in essi trova posto una grande vasca a tre gradoni per l’immersione e la successiva emersione dall’acqua, per rendere visibile il passaggio non solo simbolico dalla morte al peccato alla vita nuova in Cristo (secondo lo schema delle tre rinunce e dei tre “Credo”). Molto discussa è la presenza di figure femminili, o di possibili diaconesse, probabilmente ad esse veniva riservata una parte rilevante circa il Battesimo di donne adulte che secondo alcune consuetudini, dovevano entrare svestite nel fonte per poi rivestirsi di Cristo, in abito bianco, così anche per gli uomini.
Una fra le eccezioni più note nella storia riferisce del Battesimo all’Imperatore Costantino, che scelse il fiume Giordano quale luogo per ricevere in dono la vita nuova.
Grossomodo lo schema rituale di questo sacramento si è conservato intatto, e in esso confluì l’uso di altri elementi: l’olio, il cero… secondo varie usanze locali.
Fu il Concilio di Trento (1545-1563) a regolare una serrata disciplina. Alcune delle posizioni prese furono: lo conferma quale Sacramento, l’inserimento della Professione di Fede nel rito, la specificazione della dottrina del peccato originale causato da Adamo e dei meriti salvifici di Cristo attraverso la passione redentrice e nuove regole circa la presenza dei padrini e delle madrine (ritenendo necessaria solo una figura da porre a lato del fedele nel suo percorso) diversamente da come avveniva in epoche differenti. Così il rito rimase intatto fino al 1970.
Il Concilio Vaticano II recuperò gli aspetti teologici ampi del Battesimo, senza trascurare le abitudini rituali e rivalutando la Tradizione più antica. Il rito di oggi, quello riformato dopo il 1970, racchiude la ricchezza di tutta la storia della Chiesa e dello spessore grande degli aspetti teologici, vissuti nello specifico dell’esperienza cristiana. Ad esempio non esiste più, a partire da quell’anno, la benedizione della madre quale strumento di rimedio ad un peccato concupiscente dovuto al parto, seguendo così un criterio di discontinuità con la prassi iniziatica di matrice ebraica. Oltre a questo viene introdotto l’uso della lingua volgare – per noi l’italiano – anche se già concesso in precedenza da Papa Pio XII (nel 1943) e aboliti alcuni altri segni non in linea con la Tradizione Apostolica (soffi d’alito, imposizioni di mani sui bambini, l’uso di saliva o di sale…). Viene specificato che, cosa importante, il miglior momento per ricevere in dono il Sacramento è la Veglia Pasquale o perlomeno la Pasqua della settimana, ossia le celebrazioni Domenicali. Indipendentemente dalla confessione cristiana professata il Battesimo è considerato valido, e riconosciuto da ciascuna Chiesa, sia essa Cattolica, Orientale, Ortodossa o Protestante.
COMUNIONE
L’anno della Prima Comunione, così fino agli atti settanta, veniva impartita la lezione di dottrina – quotidiana – sulla Santa Messa, sulla confessione e sui sacramenti. Così venivano preparati i fanciulli alla Prima Comunione.
Con Papa Pio X viene anticipata l’età, prima infatti era fissata attorno ai dodici anni, al completamento del percorso di formazione cristiana prevista dal catechismo. Dal 1910 si considera la possibilità di amministrare il sacramento ai sette anni come già il Concilio Lateranense IV auspicava nel 1213. Venne così dato inizio ad una prassi diffusa, quella di celebrare una seconda Comunione solenne, esperienza oggi quasi estinta se non per alcune aree geografiche italiane che mirano a solennizzare la conclusione del percorso catechetico di V elementare, con la riscoperta alla partecipazione al Corpo di Cristo in Domenica.
In quello stesso anno, il Papa, proclamò la beata Imelda Lambertini monaca Domenicana(beatificata da Papa Leone XII), quale santa Patrona delle prime comunioni. La sua memoria liturgica è fissata il 12 Maggio. Ancora oggi, dal 1977 (anno di una missione svoltasi in Cimolais da parte dei Domenicani di Santa Maria Novella – Firenze), viene proposta ogni mese la preghiera Ora di guardia, che vede come suo iniziatore l’odine domenicano (sin dal XVII secolo), e come divulgatore l’ordine Domenicano delle Suore Imeldine, ispirato alla beata.
In quella giornata i maschi vestivano eleganti, con il cravattino, le bimbe con l’abito bianco ed il velo, come delle novizie. A loro veniva chiesto il digiuno assoluto, dalla sera prima, secondo quanto veniva richiesto prima delle riforme postume al Vaticano II. In genere la grande celebrazione di Prima Comunione veniva programmata durante la Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto), la Patrona di Cimolais, o nelle domeniche più vicine, facendo partecipare i fanciulli alla Solenne Processione. Alla Santa Messa solenne convenivano persone dai paesi vicini: Erto, Claut e Cellino.
Dopo il fenomeno migratorio degli Sessanta la data veniva rinviata al periodo natalizio, per far si che chi rientrava dall’estero vi potesse partecipare.
CRESIMA
Gli Atti degli Apostoli ci riferiscono un episodio significativo, che genera ampi dibattiti anche fra i teologi contemporanei:
«Cominciarono a credere a Filippo, che recava la buona novella del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. Anche Simone credette, fu battezzato e non si staccava più da Filippo. Era fuori di sé nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano. Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni. Essi discesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù.
Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.
Simone, vedendo che lo Spirito veniva conferito con l’imposizione delle mani degli apostoli, offrì loro del denaro dicendo: “Date anche a me questo potere perché a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo”.
Ma Pietro gli rispose: “Il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai osato pensare di acquistare con denaro il dono di Dio. Non v’è parte né sorte alcuna per te in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Pentiti dunque di questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia perdonato questo pensiero. Ti vedo infatti chiuso in fiele amaro e in lacci d’iniquità”.
Rispose Simone: “Pregate voi per me il Signore, perché non mi accada nulla di ciò che avete detto»
Atti 8, 12-24.
Questa narrazione ci fa comprendere quando già dalle prime pagine di storia della Chiesa i cristiani ebbero modo di riflettere a proposito di Confermazione. Ci sono anche altre le pagine d’interesse a tal riguardo. Volendole esaminare tutte ci suggerirebbero la plausibile esistenza di un rito antico, slegato al Battesimo e conseguente. L’eccezione avviene per la prassi sacramentale delle Chiese Orientali, che uniscono in un’unica celebrazione sia il Battesimo che la Confermazione e l’Eucaristia. Le Chiese Latine prediligono la separazione, attendendo l’età della discrezione, pertanto i fedeli battezzati la possono richiedere in funzione della loro consapevolezza.
Il Catechismo di Pio X definiva i cresimati quali: «Perfetti cristiani e soldati di Gesù Cristo» e il famoso ‘schiaffo doveva in qualche modo rappresentare la prima ferita di guerra. Questa definizione viene arricchita, oltrepassando i suoi limiti di semplicità teologica con quanto spiegato dal Catechismo della Chiesa Cattolica (documento promulgato da Giovanni Paolo II nel 1992) asserendo: «Con il sacramento della Confermazione i battezzati vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo, e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere con la parola e con l’opera la fede come veri testimoni di Cristo» (CCC, 1285).
L’unzione con l’olio del Crisma presenta numerosi significati: abbondanza, gioia, regalità, purificazione, cura, bellezza, forza… tutti elementi che specificano anche l’identità perfezionata del Battesimo. Amministra il Sacramento il Vescovo, o un suo delegato presbitero. L’olio può essere consacrato solo dal Vescovo, durante la Santa Messa del Giovedì Santo, assieme a tutti i preti della sua diocesi.
Sebbene non esista una regola precisa, i Vescovi oggi prediligono l’amministrazione del Sacramento della Confermazione dopo la celebrazione di Prima Comunione, per far in modo che i cresimandi possano partecipare pienamente al Corpo di Cristo.
MATRIMONIO
L’istituzione matrimoniale è naturale. Ossia, la Chiesa riconosce la bontà di questa forma già presente fra gli uomini, tuttalpiù si può riconoscere un perfezionamento, poiché ciascun cristiano si sente interpellato dal Vangelo a vivere secondo l’amore di Dio. Così, anche in ambito matrimoniale, è importate che il Signore sia ospite, e l’amore domestico familiare possa essere per il mondo una piccola icona di Chiesa. Chi vede gli sposi cristiani deve poter riconoscere l’amore di Cristo per la sua Chiesa (Efesini 5, 25-32). I primi secoli spingono i Padri della Chiesa verso una predicazione morale, non priva di carattere teologico, tuttavia improntata sulla necessità di vivere il matrimonio come via per evitare un approccio disordinato alla sessualità. Emblematico quanto trascrive Giovanni Crisostomo di Antiochia, morto nel 407. In continuità con gli altri Padri insegna il motivo per cui sposarsi: «affinché ci si tenga lontani dalla fornicazione» (L’unità della Nozze V, 2 ).
I testi liturgici antichi riferiscono molte preghiere che, però, definiscono anche la nuova natura, quella sacramentale, di questa unione. Nel matrimonio lo sposo e la sposa ricevono una grazia speciale, in particolare in ambito orientale.
La celebrazione del matrimonio, sin dalle origini, è unito alla Santa Messa.
Una vera formulazione del matrimonio la dobbiamo all’intervento del Concilio Lateranense IV ove, fra le postille, stabilisce la necessità di verificare i nubendi attraverso il pubblico consenso da dichiarare – addirittura – a viva voce. Assieme ad altre rubriche il Concilio venne assunto e arricchito nelle varie epoche, sempre con la chiara volontà di perfezionare la forma a questo Sacramento. Il Concilio di Firenze, nella Bolla d’unione con gli Armeni del 1439, specificherà lo scopo del matrimonio, che deve poter rendere lode a Dio con tutta la vita degli sposi, essere testimonianza di fedeltà e di indissolubilità come quella fra Cristo e la Chiesa.
Al Concilio di Trento dobbiamo la promulgazione del Decreto Tametsi (confluito poi nel Codice di Diritto Canonico del 1917) che getta le basi della prassi matrimoniale odierna. In esso si specificano le questioni che definiscono vero un matrimonio, i capi di nullità o invalidità, specifica la necessaria presenza di almeno due testimoni e che, ogni parroco, trascriva i matrimoni celebrati in un apposito registro. Al Parroco, e non ad altri, viene concessa la licenza di celebrare il matrimonio con l’unica eccezione del Vescovo.
L’abito bianco? Certamente riprende l’icona della veste battesimale. Tuttavia non è mai stato definito un colore tipico per l’abito della sposa, purché conveniente al contesto.
Anche l’usanza di partire a piedi dalla casa della sposa dove li raggiunge il suo sposo è espressione teologica, specialmente fino alla prima metà del Novecento questo uso voleva rappresentare il cammino di tutta la Chiesa-Sposa in cammino verso la Gerusalemme del Cielo (la chiesa del paese) per incontrare il Cristo-Sposo.
Il Concilio Vaticano II aggiunge che Dio stesso è autore del matrimonio e che «per la sua stessa natura l’istituto del matrimonio e l’amore coniugale sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento» (Gaudium et Spes, 48) dando rilievo rispettoso e positivo alla vita sessuale dei coniugi, definendola buona poiché favoriscono la mutua donazione, se vissuta in modo veramente umano, con gratitudine e gioia, elevata allo spirito.
Papa Francesco, in Amoris Letitia (Città del Vaticano, 2016) introduce nuove prospettive di discussione, senza anteporsi alla Tradizione o al Magistero, chiedendo agli sposi una costante trasformazione dell’amore durante la vita matrimoniale, perché continui ad essere generativo, fecondo, ricco di vita. Favorisce la riflessione per una spiritualità familiare, necessaria oggi perché gli sposi si possano sempre sentir sorretti ed accompagnati prima, durante e dopo la celebrazione del matrimonio.
LA MORTE
Attorno alla morte di un paesano si incontra viva la partecipazione di tutta la comunità. Ed è vero che la comunità cristiana si è sempre presa cura del morente e poi del defunto. L’assistenza umana, non solo nei servizi concreti, trova approdo anche nei profondi atteggiamenti spirituali del cristiano. Oggi è chiaro, la celebrazione delle esequie esprime «apertamente l’indole pasquale della morte cristiana» (Concilio Vaticano II, Costituzione Sacrosanctum Concilium, 81). Fino agli anni settanta del Novecento però, la prospettiva di fede era ben diversa. La morte apriva ad un baratro profondo, per cui la preghiera doveva sostenere la difficile ed affannosa corsa dell’anima del defunto verso il cielo. Ancora oggi, nei nostri paesi in valle, le campane che suonano, appunto “per l’anima”, osservano delle rigorose pause, per far in modo che all’affanno immaginario della corsa vi siano delle dovute soste per riprendere il respiro. Volendo offrire uno sguardo storico più ampio possiamo asserire che, nel periodo più antico della storia della Chiesa, le celebrazioni si ispiravano ampiamente a quelle proposte dagli usi pagani. La liturgia romana prevedeva la consumazione di un banchetto funebre (presente fino a non pochi decenni fa in Cimolais) e il ricordo nel terzo, settimo e trigesimo giorno dopo la morte.
Nel II secolo al banchetto i cristiani iniziano ad unire anche la celebrazione eucaristica, che inizia a trovare uno schema più consolidato, però sempre consapevoli di quanto Paolo asserisce nella Prima lettera ai Tessalonicesi, cioè che i cristiani «non vivono il lutto come coloro che non hanno speranza» (4, 13). Questo ce lo testimonia anche San Giovanni Crisostomo (+407) quando spiega: «Prima per i morti c’erano dimostrazioni di dolore e lamenti. Oggi non è più così. Si cantano inni, preghiere, salmi e tutto ciè come segno che si tratta di un evento gioioso» (Sermone sulle sante Pernica e Posdoca).
Dal Medio-evo la liturgia riprende la veste da lutto in modo così preminente che la luce tanto auspicata dai Padri viene adombrata da un pensante senso di oscurità e paura. Le preghiere per i defunti, e sui defunti, assumono una posizione dominante, intercalate dal canto del Dies Irae. Questo poi sempre più portò ad una frammentazione sul modo di celebrare l’evento nelle varie zone della futura Europa. Iniziano ad esistere celebrazioni di esequie distinte per classi. Così fino al Concilio Vaticano II, che non da alcuna preferenza circa il defunto (Sacrosanctum Concilium, 32) anzi esorta a richiamare l’indole pasquale della morte. Prima dell’ultimo Concilio, grossomodo dal tempo che intercorre dalla fine del Concilio di Trento (1545) alla prima metà del Novecento, il rito delle esequie rimane inalterato.
I paramenti sono di color nero (oggi è possibile sostituirli con il viola scuro), le preghiere rimangono molte, rigorosamente in lingua latina, meglio se cantata secondo l’uso romano. Nella casa del defunto, con la bara aperta, si svolge la veglia funebre, secondo il rituale che tutti, in quelle epoche, conoscevano quasi a memoria o possedevano in casa. Parenti, vicini e paesani: tutti si ritrovano in casa ad onorare i defunti e a pregare per loro. Il suono della campana annuncia l’ora dell’inizio e della fine della veglia, il notturno (i notturni vengono scelti in base al giorno della settimana), con il primo, ad esempio viene proposto il canto dei salmi 94, 6, 7 coi rispettivi i responsori. Ad esso si aggiungono le varie lezioni (letture tratte dal libro di Giobbe) e i responsori sempre cantati, questi però con una melodia tipica locale, tutt’oggi conservata e proposta il 2 Novembre al cimitero. Poi così anche nel giorno delle esequie, suona e annuncia la preghiera in casa, con le lodi introdotte dal Miserere (cioè il salmo 50), composte da sei salmi cantati, il Benedictus Dominus, Deus Israel (ossia il cantico di Zaccaria in Lc 1,68-79) concluso con il Pater noster (segreto fino al “et ne nos inducat”) e il De profundis prima dell’assoluzione: «Absolve, queasumus Domine, animam famuli tui [nome di battesimo] ut defectus saeculo tibi vivat…».
Prima della celebrazione della Santa Messa tutti sono radunati presso la casa del defunto e da li, a piedi, si raggiunge in corteo il tempio. Il Pievano (o il cappellano) si recano alla casa per accompagnarla alla Pieve. La Messa da Requiem, strutturata e cantata a memoria, rende partecipi tutte le voci dei presenti, con il Requiem aeternam unita al Kyrie giacchè la celebrazione ha avuto inizio in casa del defunto, l’altro momento forte è il canto della sequenza «Dies irae, dies illa, sovet saeclum in favilla, teste David cum Sibylla…». Mentre la bara viene portata all’uscita di chiesa si canta l’antifona In paradisum, e poi si impartisce la benedizione al sepolcro che – lo vogliamo ricordare – il rito prevede nei limitrofi della chiesa stessa, così fino all’Editto di Saint Claude, firmato da Napoleone nel 1804. Di fatto questo non muta il rito, sicché nei tragitti fino al cimitero, nelle epoche successive, si cantano le antifone e i salmi che il rituale prevede nel luogo di sepoltura.
Dopo il Concilio Vaticano II fu difficile abituare i fedeli ad una prassi liturgica più conveniente alle verità teologiche, questo ha generato, nostro malgrado, la tendenza a sostituire le preghiere previste con la semplice recita del rosario, pur di mantenere fissati i momenti di veglia e di preghiera alla bara.